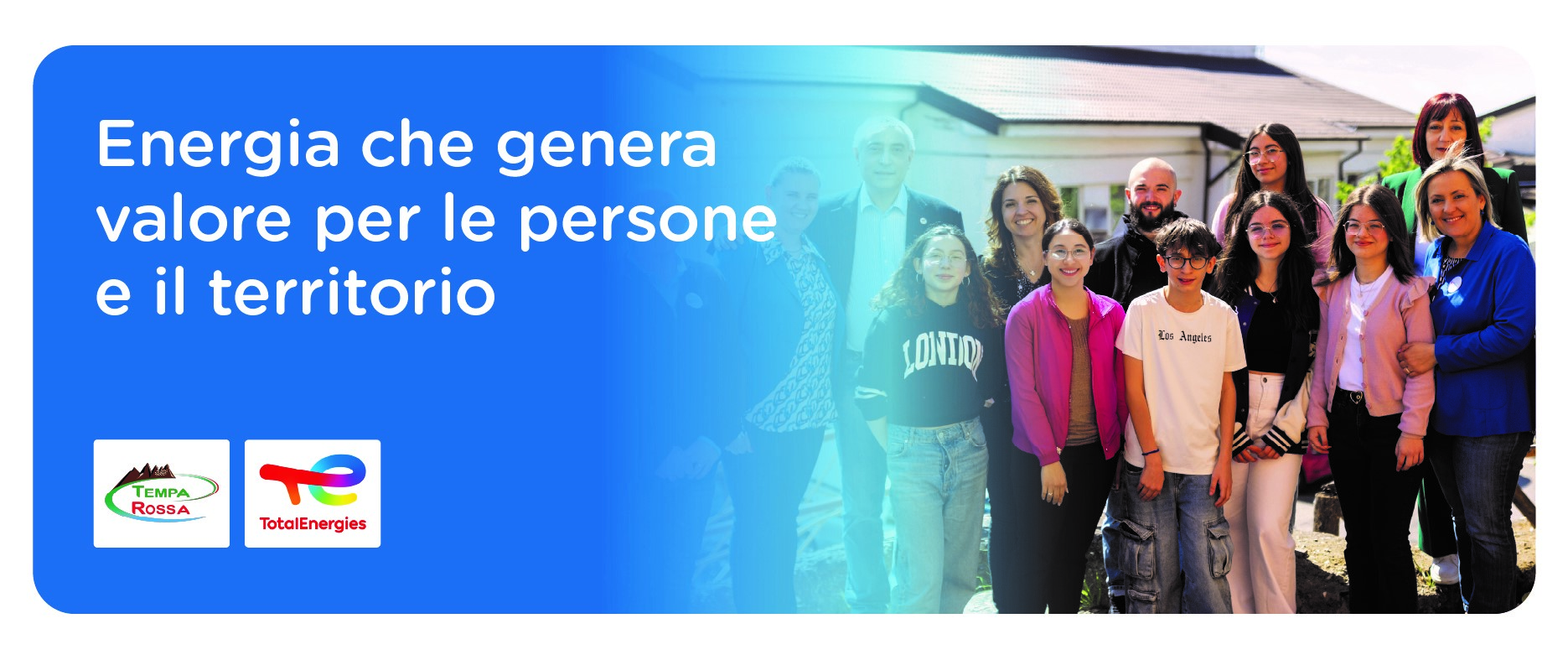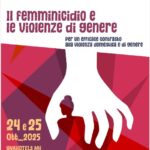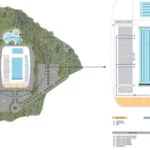Lunedì 20 ottobre 2025 – La recente operazione antidroga che ha interessato la Basilicata ed altre regioni del Sud (VEDI) ha sollevato tutta una serie di questioni, al di là della cronaca, sulle quali si soffermano in una nota Libera Basilicata e Associazione Insieme.

“Come rete impegnata nella promozione della legalità e nella lotta alle dipendenze, – affermano – esprimiamo la nostra posizione in merito alla recente operazione antidroga che ha interessato la Basilicata e il Sud Italia.
Sono 41 le misure cautelari emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza nell’ambito dell’operazione antidroga che ha interessato Ferrandina e altre province del Sud Italia.
Basilicata, Puglia, Campania, Sicilia: l’inchiesta coinvolge complessivamente 55 persone, di cui 32 arrestate (5 in carcere, 27 ai domiciliari, 7 con obbligo di dimora) e ben 7 minorenni sottoposti a provvedimenti giudiziari, due dei quali collocati in comunità.
Secondo le fonti investigative, è grande e articolato il giro di spaccio, strutturato secondo modalità mafiose e inserito in una rete di traffici tra Camorra, Mafia e criminalità organizzata del territorio.
Plaudiamo al lavoro della magistratura e delle Forze dell’Ordine, ai presìdi di legalità e di lotta alla mafia attivi dentro e fuori il territorio, al contrasto delle attività di spaccio e di fidelizzazione di nuove leve e nuovi consumatori.
Tuttavia, riteniamo necessario farne spunto di incontro e riflessione sulle profonde ricadute sociali che questi numeri ci raccontano.
Perché rispetto a questi numeri abbiamo dati precedenti e significativi, ampiamente noti e sottovalutati. Il Rapporto regionale sulle dipendenze patologiche di settembre 2025 ci consegna una fotografia allarmante della situazione regionale. Ed è proprio questo stesso quadro, caratterizzato da marginalità e indifferenza, ad essere terreno fertile per gli interessi mafiosi.
Gli utenti iscritti ai SerD della Basilicata si aggirano intorno ai 2.500, di cui 1.900 per sostanze stupefacenti. La metà del totale, se prendiamo atto di chi non arriva ad accedere ai servizi.
La media dei sequestri si attesta sui 60 kg annui, con l’eroina che resta la più diffusa tra le droghe pesanti e la cocaina che è aumentata del 124% dal 2024 al 2025.
Hashish e marijuana, invece, sono sempre meno droghe leggere, avendo di media raddoppiato e anche triplicato la presenza di THC nel giro di pochi anni.
Sono 233, invece, i minori a carico dei servizi, e per loro – per i giovani – il catastrofico problema è il crack.
Secondo la Relazione annuale del Parlamento, partendo dai dati ESPAD sugli studenti delle scuole, circa un giovane su tre ha utilizzato sostanze psicoattive. Poco di meno quelli che ne fanno uso regolarmente prima della maggiore età. La nuova, allarmante tendenza è, nella stessa fascia d’età, l’abuso di alcol e psicofarmaci, più facilmente reperibili e mischiati per aumentarne l’effetto.
La domanda che poniamo è la seguente: se a fronte di un tale mercato deve necessariamente esistere un’offerta in grado di supportarlo, come abbiamo potuto negare per anni la presenza delle mafie sul nostro territorio?
Evidentemente no. E se da una parte numeri e dati sono questi, mancano fondi e strutture per essere integralmente all’altezza, nonostante lo sforzo di associazioni, comunità e comitati cittadini.
Le politiche punitive spingono a sovraffollare le carceri di disperati, spenti e governati con l’uso massiccio di psicofarmaci e sedativi. (Se il 15% ha problemi psichiatrici e a farne uso è il 66%, evidentemente siamo di fronte a un grosso problema).
Lo diciamo sin da subito: la questione delle sostanze, delle dipendenze patologiche e del crimine organizzato è necessariamente legata. Tutto questo non può essere affrontato con il solo esercizio della repressione. Come attivisti, studiosi e professionisti in trincea da anni, lo sappiamo bene: senza prevenzione e cura non ci sarà salvezza. Ce lo dicono le carceri, in cui un detenuto su tre è un tossicodipendente che andrebbe curato, recuperato e reinserito in ambienti con personale competente e specializzato.
Tutto ciò non solo rende più difficili i percorsi di cura e reinserimento, ma favorisce e radicalizza rabbia sociale, isolamento e comportamenti criminali.
La solita, insopportabile storia: i disperati diventano carne da macello ad uso e consumo degli interessi mafiosi.
Ci rattrista leggere di come un quinto degli indagati sia un minore, già coinvolto nella rete dello spaccio o della dipendenza, soffocato da un gioco infernale in cui l’una alimenta l’altra e viceversa.
Tuttavia, questo ci porta alla domanda successiva, che ad oggi ci pare quasi una tautologia: la Basilicata è mai stata davvero l’isola felice della narrazione mediatica dominante?
Siamo certi di no, e lo denunciamo da anni.
Questo è territorio di conquista e mimetismo per cosche mafiose, ’ndranghetiste e camorristiche. Siamo al centro e negli anni abbiamo fatto spazio, sotto silenzio, un po’ a tutto l’universo del crimine organizzato. Lo hanno fatto i clan regionali, chiedendo protezione e rifornimento, offrendo spazi per il riciclaggio e l’accumulazione di ulteriori interessi economici. Lo ha permesso il silenzio di dirigenti e classe politica.
Quello che emerge dalla recente indagine, dunque, non ci stupisce. Piuttosto, ci pone dinanzi a ulteriori sfide, forse a una maggiore chiarezza rispetto alla strada da percorrere: monitorare il territorio, pretendere dati chiari sull’impatto reale delle dipendenze, portare un messaggio di legalità e impegno sociale tra i ragazzi, fare prevenzione strada per strada, scuola per scuola.
Ciò che i TG chiamano “piaga sociale” è in realtà un buco nero che si allarga e si ingigantisce insieme al potere e alla ricchezza delle organizzazioni mafiose. Eppure, rispetto a ciò, sappiamo di un intero mondo di persone impegnate in prima linea e desiderose di una società più degna. Sappiamo che esiste un’alternativa, e che deve essere politica. E sarà responsabilità di tutte e tutti, tanto della società civile quanto delle istituzioni che per anni hanno nascosto la polvere sotto il tappeto, nel peggiore dei casi con connivenze e complicità, come ci dimostrano i comuni lucani sciolti per infiltrazioni mafiose.
No, non siamo un’isola felice e non lo siamo da tempo. Siamo però un popolo degno e coraggioso, che può guardare alle decine di progetti sulla prevenzione e di intervento sociale dal basso con orgoglio e fiducia per i giorni a venire.
Non basta: sarà necessaria un’apertura sociale e politica scevra da paternalismi e criminalizzazione del disagio, attenta ai giovani e alle loro problematiche, come già le Unità di Strada tentano di fare stando nei luoghi della formazione e della socialità.
Perché liberare questa regione dalla cappa mafiosa e dal suo silenzio assordante – conclude la nota – non è solo una responsabilità morale e storica, ma un passo collettivo possibile e necessario, un atto d’amore e di civiltà”.